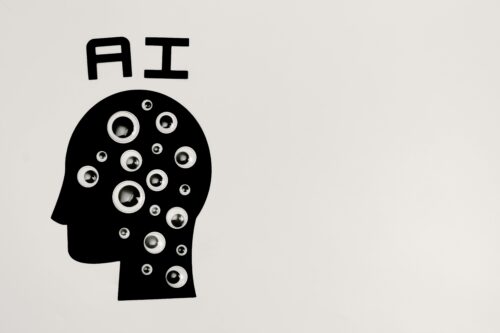 A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 settembre 2025 n. 132 la cui entrata in vigore è prevista per il 10.10.2025 sono intervenute importanti disposizioni in tema di utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale in vari settori.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 settembre 2025 n. 132 la cui entrata in vigore è prevista per il 10.10.2025 sono intervenute importanti disposizioni in tema di utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale in vari settori.
Importante, con riguardo alle disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro, l’art. 11 che stabilisce tra l’altro come “L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1 -bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152”.
L’art. 13, con riguardo alle professioni intellettuali, precisa che “1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.
L’art. 26 della Legge, “Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali”, interviene su alcune fattispecie penali, rilevanti anche ai fini della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 tra cui:
- l’art. 2637 Codice Civile – Aggiotaggio – “ Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.”
- l’art. 185 D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 – Manipolazione del mercato – “Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.
È stata inoltre prevista una nuova fattispecie di reato, con l’introduzione dell’art. 612-quater c.p. (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale) – “Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”.
L’art. 24 prevede inoltre una delega al Governo affinché dia “precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di Intelligenza Artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell’agente“.
Scarica qui la legge 132/2025 pubblicata sulla G.U.
 Complimenti ai nostri Francesca Aliverti e Pietro Gabriele Roveda per l’intervento chiaro ed esaustivo nella rubrica Incontri e Racconti su Radio Magenta.
Complimenti ai nostri Francesca Aliverti e Pietro Gabriele Roveda per l’intervento chiaro ed esaustivo nella rubrica Incontri e Racconti su Radio Magenta.
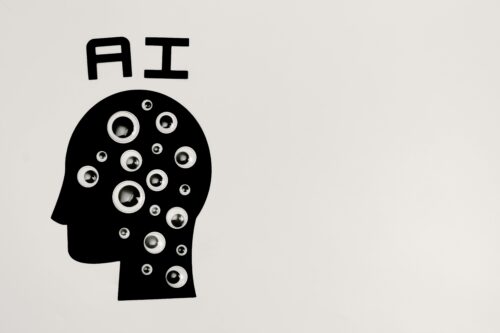 A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della  Importante pronuncia della Sezione V Penale della S.C. di Cassazione,
Importante pronuncia della Sezione V Penale della S.C. di Cassazione,  Interessante pronuncia della S.C. di Cassazione, Seconda Sezione penale, che con sentenza 15958/2025 precisa gli elementi costituivi del reato di invasione di terreni o edifici ai sensi dell’art. 633 c.p..
Interessante pronuncia della S.C. di Cassazione, Seconda Sezione penale, che con sentenza 15958/2025 precisa gli elementi costituivi del reato di invasione di terreni o edifici ai sensi dell’art. 633 c.p.. È necessaria l’indicazione espressa del nome di una persona per integrarsi reato di diffamazione ai suoi danni?
È necessaria l’indicazione espressa del nome di una persona per integrarsi reato di diffamazione ai suoi danni?