 – Contratti pubblici –
– Contratti pubblici –
Avvalimento art. 104 d.lgs. 36/2023: contratto di avvalimento non sottoscritto dalla concorrente ausiliata – Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 30 giugno 2025, n. 1149
La produzione del contratto di avvalimento da parte dell’offerente/soggetto ausiliato, che non ha sottoscritto in allegato all’offerta, vale comunque a farne proprio il contenuto con decorrenza dalla presentazione dell’offerta cui è allegato, senza che si necessario effettuare ulteriori verifiche e controlli. Al contrario, laddove nel contratto di avvalimento depositato in gara sia manchevole la firma del soggetto ausiliario, diviene centrale la verifica e la prova della data di sottoscrizione del contratto da parte dell’ausiliaria, in quanto la produzione agli atti della procedura di gara deve avvenire in modalità tale da garantire la certezza della anteriorità della sottoscrizione da parte dell’ausiliaria rispetto alla data ultima di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Ammissibilità del ribasso sui costi della manodopera nelle offerte e verifica dell’anomalia – Tar Lazio, Roma, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 12645
Anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara; sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d. lgs. n. 36 del 2023, deve pertanto ritenersi che, per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l’esclusione automatica dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia: in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali.
Risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale: la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all’art. 2702 c.c. – Const. St., Sez.V, 23 giugno 2025, n. 5444
“Il Collegio rammenta che la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale – proveniente dal creditore e rivolta al debitore – che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo sicché l’esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall’art. 2732 cod. civ. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (Cass. Civ. Sez. II, 22 febbraio 2006, n. 3921). La quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all’art. 2702 c.c. ma ha il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. Civ. Sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 24867). Nel caso qui esaminato, solo dalla certezza dell’avvenuto pagamento mediante strumenti finanziari incontestabili (anche alla luce della legislazione antiriciclaggio), poteva trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito. Non vi è traccia nella documentazione contabile del versamento dell’importo stabilito a titolo di prezzo”.
Valutazione offerte tecniche. punteggio numerico e sufficiente motivazione – Consiglio di Stato, Sez. VII, 20 giugno 2025, n. 5349
Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura di gara, con i relativi punteggi è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare l’offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità.
Risarcimento del danno curriculare: onere del concorrente di dimostrare – T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 giugno 2025, n. 1051
“La ricorrente domanda anche il risarcimento del danno curriculare, sostenendo che tale profilo di danno sia “in re ipsa” e possa risarcirsi “in una misura variabile tra l’1% e il 5% dell’importo contrattuale”.
Invero, tale assunto, non condivisibile, si fonda su una giurisprudenza, richiamata nel ricorso, che è stata superata da quella secondo cui anche il danno curriculare deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita del livello di qualificazione posseduta od al mancato conseguimento di un livello di qualificazione superiore (per gli appalti di lavori: cfr. Cons. Stato, III, 15 aprile 2019, n. 2435) ovvero al mancato raggiungimento di un fatturato utile a conseguire l’importo richiesto per partecipare a procedure di appalto di servizi o forniture bandite successivamente (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 11 aprile 2025, n.3147).
Più in generale, anche tale forma di danno risponde al principio per cui, nella materia che ci occupa, “è onere del concorrente danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei relativi presupposti, sia sul piano dell’an che sul piano del quantum, atteso che, in punto di tutela risarcitoria, l’ordinario principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal c.d. metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento ex art. 64, commi 1 e 3 cod. proc. amm., che si giustifica solo in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra Amministrazione e privato” (cfr. Cons Stato, sez. V, 13 luglio 2017, n. 3448).
Nella vicenda in esame, la ricorrente non ha fornito prova alcuna della sussistenza di tale posta di danno, sicché la relativa domanda non può trovare accoglimento.”
Sulla distinzione tra decisione amministrativa algoritmica e algoritmo di mero supporto e sull’accesso al “codice sorgente” – Const. St., Sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857
“Ritiene, infatti, il Collegio che nel caso in esame non venga in rilievo una decisione amministrativa algoritmica, ma, più limitatamente, un algoritmo di mero supporto alle decisioni che restano rigorosamente affidate al fattore umano e che, dunque, si inscrivono nella più tradizionale impostazione, che vede nell’informatica un mero ausilio rispetto allo svolgimento dell’attività amministrativa nelle sue classiche modalità operative. […]
Più in particolare:
? nella “fase 1” del procedimento, il software si limita a memorizzare le impronte digitali dei file calcolati dai partecipanti;
? nella “fase 2” del procedimento, il software raffrontare tali impronte con quelle dei file effettivamente caricati sulla piattaforma, restituendo unicamente un dato di conformità o difformità delle impronte medesime.
Sulla base di tali considerazioni è possibile confutare la tesi dell’appellante secondo cui nel caso in esame il software avrebbe compiuto decisioni automatizzate in luogo della commissione di gara e che lo stesso software ha provveduto all’automatica esclusione dell’operatore economico. […]
Ricorda il Collegio che l’adozione delle tecnologie dell’informazione, sia pure con funzione di mero supporto alla decisione affidata al fattore umano, si riflette sugli istituti del procedimento amministrativo, contribuendo alla costruzione di una amministrazione che si adatti ai mutamenti tecnologici al fine di gestire in maniera più efficiente e trasparente il procedimento”.
Sul mero atto di ritiro e sulla conseguente responsabilità precontrattuale della P.A. – T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 3 giugno 2025, n. 1917
“La revoca – di cui all’art. 21-quinquies L n. 241/1990 – è un provvedimento amministrativo di secondo grado, che postula l’esercizio di un potere discrezionale di autotutela dell’amministrazione, per ragioni di inopportunità sopravvenuta, rispetto a un atto precedentemente emanato e a efficacia durevole (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 4 dicembre 2024, n. 9701). L’annullamento ai sensi dell’art. 21-nonies L. n. 241/1990 può essere disposto, sussistendone ragioni di interesse pubblico ed entro il termine temporale indicato, nel caso di illegittimità originaria del provvedimento di primo grado.
Viceversa, laddove la pubblica amministrazione si limiti a rimuovere successivamente uno o più atti illegittimi che non abbiano ancora avuto esito in un provvedimento finale, «si è in presenza di un mero ritiro doveroso […], ben diverso dai discrezionali consueti provvedimenti di secondo grado come la revoca e l’annullamento d’ufficio, contemplati dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241» (cfr. Tar Veneto, Sez. II, 6 luglio 2023, n. 1003). Dalla diversa qualificazione di un provvedimento come atto di mero ritiro consegue che quest’ultimo «non è subordinato alla previa verifica della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, non necessita della valutazione delle posizioni soggettive eventualmente coinvolte nella vicenda e non richiede il previo avviso di inizio del procedimento» (cfr. Tar Veneto n. 1003/2023 cit.; in termini, cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. III, 24 ottobre 2024, n. 5632; id., 7 marzo 2024, n. 1537). […]
I principi suddetti sono pianamente applicabili al caso di specie, ove è stata ritirata l’intera procedura di gara prima di addivenire all’aggiudicazione. […]
In altre parole, nel caso di specie la stazione appaltante si avvedeva di aver introdotto un ostacolo alla concorrenza senza che vi fosse una giustificazione tecnica per la richiesta della marcatura CE e provvedeva a rimuovere doverosamente una causa di invalidità della stessa procedura di gara che non avrebbe mai dovuto svolgersi con quel contenuto. […]
La domanda di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale è infondata.
Anzitutto va evidenziato che le decisioni della stazione appaltante circa l’emanazione di un nuovo bando di gara e la fornitura tramite proroga tecnica sono aspetti estranei alla fattispecie risarcitoria da responsabilità precontrattuale, poiché nulla hanno a che vedere con l’affidamento riposto dalla società offerente circa la conclusione della procedura di gara e la stipulazione del contratto.
In secondo luogo, non può dirsi che la società abbia riposto un incolpevole affidamento sulla conclusione della gara e aggiudicazione in suo favore, poiché ha partecipato a una gara dalla quale era anzi perfettamente consapevole di dover essere esclusa.
Cause non automatiche di esclusione (ammissione ed esclusione): onere motivazionale – T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 giugno 2025, n. 2456
“Costituisce, invero, regola generale – da ritenersi valida anche nel vigore del d.lgs. n. 36/2023 – quella secondo cui la stazione appaltante che sia venuta a conoscenza di condotte astrattamente ascrivili alle cause non automatiche di esclusione deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2025, n. 3191; Cons. Stato, V, 5 maggio 2020, n. 2850; VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons. Stato, VI, 21 maggio 2014, n. 2622; III, 24 dicembre 2013, n. 6236; V, 30 giugno 2011, n. 3924; III, 11 marzo 2011, n.1583; VI, 24 giugno 2010, n. 4019; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n. 2001/2021; T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 07/04/2021, n.2294; Tar Toscana, sent. n. 291/2022; Tar Lazio, Roma, sent. n. 9984/2025).
Per giurisprudenza costante, dunque, la stazione appaltante che non ritenga le condotte dichiarate dal concorrente incisive della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità delle relative circostanze risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa; è la valutazione di gravità, semmai, che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale, con la conseguenza che la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni (Cons. Stato, sez. V, n. 2580/2020; sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8081; n. 3198/2016; C.G.A.R.S., n. 53/2015; Cons. Stato, sez. VI, n. 2622/2014; sez. III, n. 6236/2013; sez. V, n. 3924/2011; sez. III, n. 1583/2011; sez. VI, n. 4019/2010). […]
La carenza di motivazione del provvedimento di ammissione a una gara pubblica di un concorrente, pertanto, non può, pertanto, di per sé implicare un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla rilevanza delle circostanze dichiarate dal concorrente: a ciò consegue che chi dissente dalla valutazione dell’amministrazione non può limitarsi ad addurre il difetto di motivazione, ma deve contestarla adducendo elementi concreti e puntuali, idonei a dimostrare l’inattendibilità del giudizio tecnico-discrezionale avversato, cosa che, nel caso di specie, la ricorrente non ha fatto.”
***
– Processo amministrativo –
Sul superamento dei limiti dimensionali negli atti processuali – Cons. St., Sez. III, 5 giugno 2025, n. 4902
Il Consiglio di Stato ha richiamato la sentenza n. 3 del 2025 resa dall’Adunanza plenaria nella quale ha stabilito che “l’art. 13-ter, comma 5, dell’allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è norma di natura processuale che definisce i poteri del giudice per i casi in cui, senza autorizzazione, gli atti non abbiano rispettato i limiti dimensionali”
Sulla base di tali indicazioni, “configurata come facoltà del giudice di condannare la parte autrice della trasgressione “al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato”.
Ad avviso del Collegio, “effettivamente l’appellante non aveva alcun motivo di riproporre in apertura del proprio ricorso la pletorica e tutto sommato superflua ricostruzione del giudizio di primo grado, che costituisce la causa unica dello sforamento dei limiti dimensionali; mentre le deduzioni difensive riportate nella memoria depositata il 6 dicembre 2024 si sono rivelate del tutto infondate o pretestuose (come evidenziato nell’ordinanza n. 352 del 2025), sicché le stesse non hanno fornito alcuna plausibile giustificazione retrospettiva al menzionato sforamento”.
Di conseguenza, “considerato l’importo del contributo unificato del presente giudizio (€ 450,00), appare equo condannare l’appellante al pagamento di una somma aggiuntiva di € 600,00”.
***
– Ambiente –
Autorizzazione integrata ambientale: annullamento d’ufficio a causa della falsa rappresentazione dello stato dei luoghi – Cons. St., Sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4859
“Il provvedimento impugnato ha disposto la revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e della V.i.a., perché ha ritenuto che la Fiotech s.r.l. non avesse rappresentato un quadro corretto dello stato dei luoghi: in particolare, la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ha evidenziato che nello studio di impatto ambientale predisposto dai tecnici di parte appellante erano stati riportati dati non corrispondenti a quanto certificato dal Comune di Cassino (con certificazione dell’area tecnica comunale del 29 ottobre 2018 del Comune di Cassino), in particolare sulla presenza di insediamenti abitativi nel raggio di cinquecento metri, nonché di siti sensibili nel raggio di 2 km.
Il T.a.r. ha condiviso il percorso argomentativo dell’amministrazione.
Ritiene il Collegio che la sentenza del T.a.r., così come il provvedimento di revoca impugnato, sia immune dalle censure mosse dall’appellante, in quanto dalla nota non tecnica dell’appellante del 10 aprile 2012, che ha sostituito quella precedente, si legge a pag. 17 che: “per quanto riguarda la prevenzione di possibili situazioni di disagio percepiti dalla popolazione, si fa presente che non vi è nella zona una continuità abitativa anche se è presente un gruppo di case sparse, né presenza di edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici e impianti sportivi, né aziende di tipo alimentare.”
Il Comune di Cassino ha, invece attestato con certificazione dell’area tecnica comunale del 29 ottobre 2018, che nel raggio di meno di due chilometri si trovavano circa “50 abitazioni in cui vivono 52 nuclei familiari” con bambini ed anziani, oltre al complesso scolastico “ISS San Benedetto”, con oltre seicento alunni iscritti, e due case di riposo per anziani, una caserma dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale, nonché diverse aziende agricole ristoranti e agriturismi. […]
Nessun indennizzo naturalmente spetta a parte appellante, in quanto, correttamente il T.a.r. ha qualificato il provvedimento di revoca come un provvedimento di annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990, stante l’illegittimità dei provvedimenti ritirati emessi sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti”.
***
– Pubblica sicurezza –
Porto d’armi e reati ostativi: gli effetti della riforma “Cartabia” sulla sentenza di patteggiamento – T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 3 giugno 2025, n. 1736
“Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia, fondato sull’intervenuta sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 69,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 del c.p., “furto aggravato di energia elettrica” con sospensione condizionale della pena, irrogata con sentenza dal Tribunale di -OMISSIS- (divenuta irrevocabile il -OMISSIS-).
A sostegno del gravame, la parte ricorrente ha contestato l’idoneità e la sufficienza della condanna in esame a fondare un giudizio negativo in ordine alla sussistenza della buona condotta tenuto altresì conto che l’art. 445 comma 1-bis c.p.p. ha sancito l’irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giudiziario diverso da quello penale […]
La giurisprudenza ha costantemente affermato che la nozione di condanna rilevanti ai sensi dell’art. 43, comma 1, t.u.l.p.s., deve estendersi anche all’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. anche ove condizionalmente sospesa (Cons. Stato, sez. I, 11 luglio 2016, n. 1620).
Il predetto automatismo, ancorato anche alla sentenza ex artt. 444, c.p.p., deve ritenersi eliminato dal novellato (ad opera dell’art. 25, lett. b) del d.lgs. n. 150/2022) art. 445, comma 1-bis c.p.p. (secondo cui “La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile” e che per la giurisprudenza prevalente si applica anche alle sentenze di patteggiamento emesse prima della sua entrata in vigore [cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 29 aprile 2024, n. 524]) che ha escluso ogni possibilità di equiparare la sentenza di patteggiamento a quelle di condanna (T.a.r. per la Toscana, sez. IV, 24 febbraio 2025, n. 295).
Venuto meno il predetto automatismo, il mero ed esclusivo riferimento al furto di energia elettrica non è idoneo a fondare il diniego, trattandosi di fattispecie di reato non immediatamente collegabile all’uso delle armi, non comportando attività violenta o comunque direttamente ipoteticamente incidente a tale uso.
La Sezione ha avuto modo di chiarire (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 13 dicembre 2024, n. 4096, 25 ottobre 2024, n. 3477) come allorché venga in rilievo un fatto che non è connesso all’uso delle armi e che obiettivamente non può essere considerato di per sé indicativo o sintomatico di una personalità violenta o di un carattere instabile o impulsivo, la possibilità di porlo a fondamento di un provvedimento di divieto di detenzione armi richiede l’indicazione di quelle “particolari contingenze” (T.a.r. per la Valle d’Aosta, 26 gennaio 2018, n. 8), nel caso di specie mancante.
E invero, non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi ai fini dell’applicazione dell’art. 43, comma 2, del T.u.l.p.s. onde escludere la buona condotta o l’affidamento di non abusare delle armi. E invero, qualora risultino reati commessi proprio mediante l’uso (o l’abuso) delle armi, l’inaffidabilità del soggetto emerge ictu oculi, sicché i provvedimenti ostativi non abbisognano, in genere, di altra motivazione, mentre quanto più ci si allontana da detta ipotesi, tanto più esauriente dovrà essere la motivazione con la quale si dia conto delle ragioni per cui un determinato fatto illecito sia stato ritenuto significativo (cfr., ex plurimis, T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 27 novembre 2023, n. 2818; T.a.r. Veneto, sez. I, 8 luglio 2019, n. 812)”.
***
– Edilizia e urbanistica –
Ristrutturazione demo-ricostruttiva con traslazione dell’area di sedime su un diverso lotto: il punto del Consiglio di giustizia amministrativa – C.G.A.R.S., Sez. giur., 3 giugno 2025 n. 422
“Dopo le innovazioni apportate all’art. 3 co. 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001 dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 la predetta nozione è stata notevolmente ampliata, non postulando più il rispetto di tutti quei parametri originariamente ritenuti essenziali per la sua configurabilità. La norma, infatti, adesso include nella ristrutturazione edile anche la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti “con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.
Deve, dunque, concepirsi adesso la ristrutturazione edile secondo la rinnovata ottica desumibile dal tenore testuale della disposizione in esame volta a non vincolarla ai precedenti requisiti presupponenti una rigida “continuità” tra le caratteristiche strutturali dell’immobile preesistente e quelle del manufatto da realizzare, ivi inclusa l’area di edificazione.
La nozione di sedime richiamata nella nuova formulazione dell’art. 3 lett. d) D.P.R. n. 380/2001 è, infatti, molto generica e non riporta alcuna specificazione.
Donde, l’impossibilità di limitarne il concetto all’ambito perimetrale di un determinato lotto. […]
Il sedime è, infatti, la superficie di terreno sulla quale poggiano le fondazioni di un edificio o di un manufatto edile, essendo la proiezione longitudinale della costruzione sul terreno, e, quindi, non coincide con l’area di un intero terreno catastalmente censito.
Di conseguenza, la riconosciuta possibilità di demolire un fabbricato esistente e di ricostruirlo su un’altra area, ossia su un diverso sedime, non può ritenersi soggetta ai limiti dimensionali del terreno originariamente interessato dalla costruzione da ristrutturare, potendo, dunque, ammettersi la ricostruzione anche altrove, ossia in un diverso lotto, pur sempre nel rispetto delle capacità edificatorie proprie di quest’ultimo. […]
Né, peraltro, può ritenersi che la nuova concezione della ristrutturazione edile implichi “consumo di nuovo suolo”, poiché la scelta di ricostruire altrove presuppone pur sempre la necessità di demolire da un’altra parte e, pertanto, postula un bilanciamento tra l’edificio da realizzare e quello da eliminare.
Il che segna l’elemento distintivo della nuova ristrutturazione edile, così come delineata dall’art. 3 co. 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001 modificato dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, rispetto alla nuova costruzione di cui all’art. 3 co. 1 lett. e) D.P.R. n. 380/2001, poiché la prima presuppone pur sempre la demolizione di un preesistente manufatto a differenza della seconda che si afferma quale categoria residuale comprendente gli interventi non riconducibili in altre casistiche e, quindi, anche l’attività edificatoria del tutto autonoma ed indipendente da eventuali preesistenti edifici da demolire”.
Inapplicabilità del silenzio assenso nel procedimento di compatibilità paesaggistica – T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 11 giugno 2025, n. 4406
“La violazione del termine di cui all’art. 167, co. 5, del d.lgs. n. 42/2004 non comporta la formazione del silenzio-assenso, in ragione dell’inapplicabilità ai procedimenti di compatibilità paesaggistica della disciplina generale prevista dall’art. 17-bis della l. n. 241/1990. […]
Il c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio ha introdotto una procedura co-decisoria tra due Amministrazioni, segnatamente la Soprintendenza, competente nel rendere un parere vincolante, e l’Amministrazione preposta alla tutela paesaggistica, chiamata ad assumere la decisione finale, che si realizza secondo modalità peculiari, che non presuppongono un simmetrico potere di ciascuna parte pubblica di influire sul contenuto della decisione finale. […]
Peraltro, il parere della Soprintendenza è qualificato come vincolante, con la conseguenza che “a fronte del carattere vincolante del parere soprintendentizio ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004, non persiste […] margine alcuno di valutazione difforme in capo all’Amministrazione comunale” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2018, n. 2245).
In altri termini, “deve ritenersi che l’inutile decorrenza del termine perentorio di novanta giorni ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/04 determini – anziché la formazione di un atto di assenso tacito, a conferma dell’inapplicabilità dell’art. 17 bis l. n. 241/90 – la decadenza dalla possibilità di vincolare l’amministrazione procedente nella decisione finale; il che, tuttavia, non impedirebbe all’organo statale di intervenire nel procedimento per fornire il proprio contributo partecipativo, ponendo in essere un atto non obbligatorio e non vincolante” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 novembre 2020, n. 7193).
Pertanto, in caso di espressione di un parere soprintendentizio tardivo, l’Amministrazione competente per il rilascio del provvedimento finale, valutando autonomamente tale contributo, al pari di quanto avviene per ogni elemento istruttorio, è tenuta, in ogni caso, a motivare in modo autonomo le ragioni per le quali l’intervento di trasformazione territoriale non sarebbe compatibile con i vincoli imposti dalle esigenze di tutela paesaggistica (ex multis: Cons. Stato, sez. VII, 4 gennaio 2023, n. 168; Cons. Stato, VI, 17 novembre 2022, n. 10109; 19 agosto 2022, n. 7293; 24 maggio 2022, n. 4098; 29 marzo 2021, n. 2640; 19 novembre 2020, nn. 7192 e 7193)”.
***
– Corte Costituzionale –
Giudizio di legittimità costituzionale sul termine di 12 mesi per l’annullamento in autotutela, anche in presenza di interessi pubblici di rango primario – Corte cost. 26 giugno 2025, n. 88
Il nucleo motivazionale della sentenza della Corte costituzionale ruota attorno al riconoscimento della legittimità costituzionale del termine massimo di dodici mesi per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi favorevoli, previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990. La Corte afferma che tale limite temporale, pur incidendo anche su atti riguardanti interessi di rilievo costituzionale, come la tutela del patrimonio culturale, rappresenta una scelta legislativa non manifestamente irragionevole. Il termine risponde infatti all’esigenza di garantire certezza giuridica e tutela del legittimo affidamento del privato, valori anch’essi costituzionalmente rilevanti. Viene inoltre sottolineato che l’ordinamento prevede già una deroga per i casi in cui il provvedimento sia stato ottenuto con dichiarazioni false o mendaci, così escludendo la tutela dell’affidamento non meritevole. In tal modo, il bilanciamento tra interesse pubblico e affidamento privato risulta rispettoso del principio di proporzionalità e del buon andamento dell’amministrazione.
***
– Chiarimenti ANAC –
Qualificazione delle stazioni appaltanti: nuove indicazioni generali e chiarimenti – Chiarimenti Pres. Busia 30 giugno
Dal 1° luglio 2025 è pienamente operativo il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
Le stazioni appaltanti dovranno programmare l’invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative.
Secondo quanto chiarito dalla comunicazione a firma del Presidente dell’Autorità, “la eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione”.
Quanto alle procedure da avviare, per quelle sottosoglia non si determina alcun blocco nel rilascio del CIG, mentre, per quelle soprasoglia, “le amministrazioni non qualificate potranno avvalersi di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata”.
La qualificazione ottenuta ha durata biennale a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Chiarisce ANAC in relazione alla qualificazione del personale, indispensabile per un’amministrazione efficiente ed efficace che:
- rileva la formazione svolta nel triennio precedente la domanda;
- dal 1° gennaio 2025 potranno essere autocertificati esclusivamente i corsi accreditati SNA;
- i corsi non accreditati SNA saranno comunque validi se svolti entro il 31 dicembre 2024.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili nel Documento tecnico di indirizzo, approvato con delibera n. 236 del 3 giugno 2025.
***
Sommario
Contratti pubblici
- TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 30 giugno 2025, n. 1149
Avvalimento art. 104 d.lgs. 36/2023: contratto di avvalimento non sottoscritto dalla concorrente ausiliata
- TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 giugno 2025, n. 2456
Cause non automatiche di esclusione (ammissione ed esclusione): onere motivazionale
- TAR Lazio, Roma, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 12645
Ammissibilità del ribasso sui costi della manodopera nelle offerte e verifica dell’anomalia
- Consiglio di Stato, Sez. V, 23 giugno 2025, n. 5444
Risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale: la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato
- Consiglio di Stato, Sez. VII, 20 giugno 2025, n. 5349
Valutazione offerte tecniche. punteggio numerico e sufficiente motivazione
- TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 giugno 2025, n. 1051
Risarcimento del danno curriculare: onere del concorrente di dimostrare
- Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857
Distinzione tra decisione amministrativa algoritmica e algoritmo di supporto; accesso al codice sorgente
- TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 3 giugno 2025, n. 1917
Sul mero atto di ritiro e sulla conseguente responsabilità precontrattuale della P.A.
Processo amministrativo
- Consiglio di Stato, Sez. III, 5 giugno 2025, n. 4902
Superamento dei limiti dimensionali negli atti processuali
Ambiente
- Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4859
Autorizzazione integrata ambientale: annullamento d’ufficio per falsa rappresentazione dello stato dei luoghi
Pubblica sicurezza
- TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 3 giugno 2025, n. 1736
Porto d’armi e reati ostativi: effetti della riforma “Cartabia” sulla sentenza di patteggiamento
Edilizia e urbanistica
- TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 11 giugno 2025, n. 4406
Inapplicabilità del silenzio assenso nel procedimento di compatibilità paesaggistica
- C.G.A.R.S., Sez. giur., 3 giugno 2025, n. 422
Ristrutturazione demo-ricostruttiva con traslazione dell’area di sedime su un diverso lotto
Corte Costituzionale
- Corte cost., 26 giugno 2025, n. 88
Giudizio di legittimità costituzionale sul termine di 12 mesi per l’annullamento in autotutela
Chiarimenti ANAC
- Chiarimenti Pres. Busia, 30 giugno 2025
Qualificazione delle stazioni appaltanti: indicazioni generali e chiarimenti
Contatti:
Francesca Aliverti – Avvocato
Via G. Donizetti 2
20122 Milano
02.5455732 – info@arclex.it
Domenico Greco – Avvocato
Via Giuseppe Gioachino Belli, 60
00193 Roma
06.45771530 – info@arclex.it
 Complimenti ai nostri Francesca Aliverti e Pietro Gabriele Roveda per l’intervento chiaro ed esaustivo nella rubrica Incontri e Racconti su Radio Magenta.
Complimenti ai nostri Francesca Aliverti e Pietro Gabriele Roveda per l’intervento chiaro ed esaustivo nella rubrica Incontri e Racconti su Radio Magenta.
 L’art. 2495 co. 3 c.c. stabilisce “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.
L’art. 2495 co. 3 c.c. stabilisce “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.
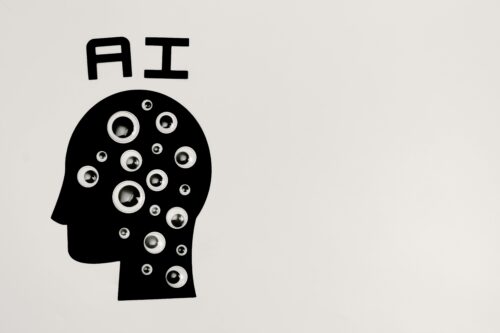 A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della  – Contratti pubblici –
– Contratti pubblici –